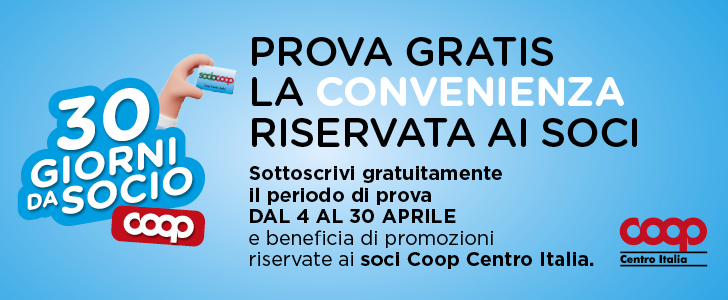È chiaro che in questi tempi calamitosi ognuno si fa in tasca propria i conti delle personali disgrazie.
Uno dei settori meno conosciuti tra quelli messi in sofferenza dalle non sempre condivisibili misure messe in atto per contrastare gli effetti della pandemia, è quello dell’editoria musicale.
Chi oggi voglia proporre un testo di musicologia, per quanto prezioso possa essere, si scontra con ostacoli non sempre logici che frenano non solo l’operatività editoriale, ma anche la minima possibilità di rendere fruibile al pubblico quel poco che si è riusciti a pubblicare, spesso a prezzo di enormi sacrifici.
In questo caso l’appello viene dalla autorevole persona della presidente della Fondazione Perugia Musica Classica, già alle prese con le angustie degli Amici della musica, ma non per questo insensibile a un appello che viene dalla lontana Brescia, la indomita “leonessa d’Italia” che seppe resistere alla soldataglia di Radetzky, ma che ora vive la non invidiabile situazione di essere proprio nel cratere della pandemia. La nostra città, martire anch’essa delle sofferenze risorgimentali, può ben accogliere l’appello a una concordia di intenti che, a orizzonte ripristinato, potrà essere ricordata come una condivisione umana e culturale.
Commentare un volume di quasi duecento pagine che, per la copertina in brossura e la scelta di una carta patinata a prova di usura, pesa circa quattro chili, è un’impresa che richiede anche una certa componente fisica solo nel reggere tra le mani il testo.
Ma la fatica è ben ripagata dallo scorre le pagine che contengono la descrizione di un generoso sforzo dell’editoria del passato. La Biblioteca musicale Franchi di Brescia mette a disposizione degli utenti il catalogo di “Le trésor de pianistes”, ovvero il tesoro dei pianisti, un modello antologico di musiche per tastiera composte tra il XVI e il XIX secolo e inserite, come “Monumento musicale” nella Enciclopedia della musica e dei musicisti, la mitica panoplia della gloriosa Utet, la casa editrice torinese da poco passata a miglior vita.
Elena Franchi, la responsabile del progetto della omonima biblioteca, nella prefazione datata Milano, ottobre 2020, ricorda come l’impareggiabile sforzo di catalogare e mettere a regime l’elenco dei dati sia stato frustrato, proprio nella sua fase finale, dal soffio del morbo. Ma, come si sa, la cultura non si distrugge e non si può fermare, ed eccoci tra le mani, anzi tra le braccia, questo ponderoso volume, una sorta di lastra di marmo sulla quale è stata incisa una delle più belle avventura del pensiero musicale europeo.
Il Trésor venne redatto e compilato da un musicista ed editore francese, Aristide Farrenc, che lasciò alla moglie, Jeanne Louise, il compito di completare una raccolta che, in 23 volumi, voleva raccogliere gran parte dello scibile pianistico dell’epoca, partendo dai precursori della tastiera, i virginalisti e i clavicembalisti per Seicento. In un’epoca in cui non si sapeva niente di Vivaldi e Bach era ancora un lusso condiviso da pochi, questa antologia voleva essere uno sforzo del pensiero scientifico in un momento storico in cui, in tutto il continente, dilagava la profluvie del melodramma. Strumento principe del salotto della buona borghesia, da Jane Austen alla contessa Belgioioso, si ascoltavano Chopin e Liszt, ignorando come le loro vorticose armonie venissero da un passato che aveva avuto i suoi presocratici della tastiera che ancora non si chiamava pianoforte. Ma era proprio il pianoforte, il manufatto sonoro perfezionato dalla rivoluzione industriale, a rivestire la capacità di far rivivere musiche spente, seppellite dalla polvere delle biblioteche, magari celate in soffitte polverose allo stato di faldoni cartacei corrosi dall’umidità. E’ grazie a operazioni come questa del Trésor che si è salvato un patrimonio musicale con cui oggi la storia può fare i suoi conti, amministrando con consapevolezza scientifica una eredità storica gelosamente conservata. Edito in 23 volumi tra il 1861 e il 1872 il Trèsor venne diffuso in tempi concomitanti a Parigi, a Londra, presso Cramer, a Lipsia presso la prestigiosa Breitkopf & Haertel, la casa editrice di Schumann e Brahms. Farrenc si avvalse, per il suo sforo editoriale, della consulenza di Fetis, il Socrate dei musicologi francesi, autorità indiscussa della storiografia. Le sue scelte, la selezione del materiale, la curatela di presentazioni storiche e stilistiche conferivano alla raccolta una dignità scientifica piuttosto elevata per l’epoca. Già allora, ovviamente, riproporre al pianoforte pezzi scritti per spinetta, virginale e clavicembalo, suscitava perplessità filologiche, Ma questi arcaici strumenti, andati in malora e spariti dalla organologia, trovavano nel pianoforte le ragioni di una sopravvivenza di quanto era stato scritto per le loro gracili tastiere. Se è vero che la più antica forma di musica per una ipotetica tastiera è il “Frammento Robertsbridge” del 1360, prezioso reperto della British Library di Londra, è altrettanto pacifico che, sin da allora, raccogliere su una piattaforma sinottica una qualunque forma di musica, voleva dire conservarla, anche sinteticamente, per la trasmissione a esecutori delle epoche successive. In tal senso va vista come una incredibile realizzazione la trascrizione di Fetis e di Farrenc di “Partenia” una raccolta londinese del 1611. in cui tre virginalisti dell’epoca, Byrd, Gibbons e Bull venivano sdoganati dall’oblio in una fruizione pianistica certamente “infedele” all’acustica originaria, ma l’unica disponibile, in quel momento, per una conservazione monumentale, ma anche pragmatica.
La selezione antologica dei 23 volumi che vennero acquistati dal lungimirante bresciano Gaetano Franchi prosegue con i maestri italiani quali Merulo e Frescobaldi e con gli oltremontani Muffat, Chambonnieres e D’Anglebert. Scorrendo velocemente i primi testi, che annoverano personaggi come Couperin, Purcell, Haendel, si giunge a Bach accostato, a pari merito a Rameau e a Porpora. Oggi, si ragiona col senno del poi, ma allora, dopo l’exploit lipsiense di Mendelosshn degli anni ’30, il Cantor ancora uno sconosciuto. Bisogna arrivare al sedicesimo volume del Trésor per trovare il nome del fondatore della moderna didattica pianistica, Muzio Clementi, mentre il tomo seguente elenca le sonate e le variazioni di Mozart. Tre volumi, sino al ventiduesimo, sono destinati a raccogliere l’integrale sonatistica beethoveniana, mentre il 23esimo, il terminale, chiude con un Mendelssohn, un Ries, un Weber accostati a Chopin, di cui si danno solo alcuni Notturni.
Con commovente dedizione, quasi una chiusa da romanzo di Bassani, Elena Franchi ricorda: «L’immagine della collezione, con i suoi grandi volumi collocati nella casa di mi nonno e poi di mio padre nella parte più alta della biblioteca, indicava con la sua inaccessibilità il valore imperituro che esercitava nella mia educazione e nella mia formazione. Con questo spirito ho cercato di raccontare».
Ora questo marmoreo testo, con le sue precise schede analitiche che elencano, volume per volume, autori e pezzi raccolti, è un forte strumento messo a disposizione degli studiosi che vogliano approfondire l’enorme lascito di storia e di civiltà che la cultura della borghesia lombarda ha lasciato alla modernità, un vero e proprio “Gradus ad Parnassum” della storia del pianoforte. È augurabile che, a morbo archiviato, qui agli Amici della musica, si possa realizzare una presentazione del volume che, per le sue dimensioni, risulta di difficile fruizione, ma che non per questo deve restare una iniziativa isolata e ignorata dal grande pubblico della musica.
Stefano Ragni